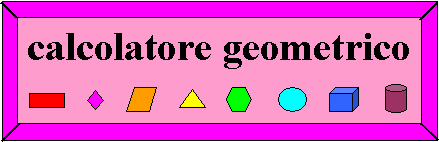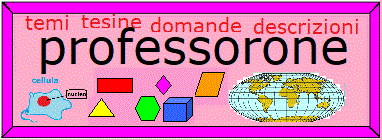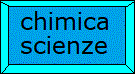Camera 10 giugno 2008
Audizione del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle
linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente agli aspetti attinenti il
settore dell'istruzione.
Signor presidente, onorevoli deputati, il
grande rispetto che nutro per il lavoro del Parlamento e l'importanza che
assegno al confronto con le Commissioni mi hanno indotto a chiedere  al
presidente Aprea e al presidente Possa di separare in due distinti momenti la
mia audizione. Istruzione, università e ricerca scientifica costituiscono un tutt'uno,
hanno per protagonista lo stesso soggetto, la persona nel suo cammino di
crescita e di conoscenza, e sono parte dell'unica infrastruttura dell'educazione
e del sapere. Tuttavia, la loro complessità, la diversità di linguaggi e in
parte di problemi, la necessità di focalizzare sia pure a grandi linee il
dibattito e di dare alla Commissione la più ampia possibilità di esprimersi
meritano da parte di tutti noi l'esercizio di un duplice sforzo.
al
presidente Aprea e al presidente Possa di separare in due distinti momenti la
mia audizione. Istruzione, università e ricerca scientifica costituiscono un tutt'uno,
hanno per protagonista lo stesso soggetto, la persona nel suo cammino di
crescita e di conoscenza, e sono parte dell'unica infrastruttura dell'educazione
e del sapere. Tuttavia, la loro complessità, la diversità di linguaggi e in
parte di problemi, la necessità di focalizzare sia pure a grandi linee il
dibattito e di dare alla Commissione la più ampia possibilità di esprimersi
meritano da parte di tutti noi l'esercizio di un duplice sforzo.
Oggi, quindi, discuterò con voi dalla scuola primaria e secondaria. È
necessario sottolineare innanzitutto un aspetto che mi preme e che ritengo voi
abbiate il diritto di sapere e io il dovere di esprimere, ovvero il criterio
affettivo, il sentimento razionale con cui ho deciso di accettare questo
incarico gravoso ed esaltante. So bene che esso è pesato su spalle di grandi
filosofi e di eminenti letterati, ai quali non mi permetto certo di paragonarmi,
se non per l'essenziale, che non è la scienza e la cultura, ma la passione per
l'educazione, il desiderio che questa Italia cresca nel bene più prezioso che
oggi si usa definire «capitale umano», ma che più semplicemente si chiama «persona».
In continuità con l'intendimento delle famiglie, la scuola è il luogo primo e
decisivo di questa possibilità, in cui sola sta la speranza. Per definire la
crisi che attraversa non solo l'Italia ma l'intero Occidente, il Santo Padre non
ha esitato a parlare di «emergenza educativa» come del punto di debolezza
maggiore della nostra società, parole che rispecchiano i sentimenti di
preoccupazione che il Presidente Napolitano ha voluto manifestarmi.
Nel dibattito sulla fiducia lo scorso 13 maggio, questa espressione è stata
richiamata dai deputati di entrambi gli schieramenti, in particolare dagli
onorevoli Renato Farina del Popolo della Libertà e Marina Sereni del Partito
democratico.
L'emergenza educativa non si affronta
semplicemente con nuovi contenuti e nuove metodologie pur utili, né con il
richiamo a valori astrattamente affermati. I valori, per essere condivisi e
vissuti, devono essere convincenti per i ragazzi, come sono quando testimoniati
da adulti (genitori, insegnanti, personale non docente), che propongono un senso
positivo della vita.
Signor presidente, onorevoli deputati, ho deciso in queste settimane di
mantenere il più assoluto riserbo sulle linee di indirizzo, salvo rispondere ad
alcune urgenze rispetto alle quali il silenzio del ministro poteva essere male
interpretato. Non ho concesso interviste né scritto articoli, ma ho invece
iniziato a studiare i dossier, a leggere quanto di buono o meno buono è
stato scritto in questi ultimi anni sulla scuola, a riflettere per impostare
proposte ragionevoli e utili.
Oggi non intendo fare la lista della spesa, soprattutto perché i singoli
capitoli di questa lista meritano (e credo li avranno) momenti di confronto
focalizzato. Intendo invece esporre i princìpi e i metodi di un piano di
legislatura. Sono sicura che il presidente della Commissione, l'onorevole
Valentina Aprea, sia la persona più qualificata, anche per temperamento ed
indole, a trasformare questo metodo in realtà quotidiana.
Signor presidente, onorevoli deputati, il Governo e il ministro hanno piena
consapevolezza dei gravi e complessi problemi della scuola. Consentitemi di
risparmiarvi una serie di dati di largo e pubblico dominio e di valutazioni, che
in questi ultimi mesi ho visto largamente condivise, limitandomi solo ad alcuni
numeri fondamentali.
Nelle comparazioni internazionali i nostri studenti risultano tra i più
impreparati d'Europa. Le indagini OCSE-PISA, che misurano le competenze in
ambito matematico e scientifico, la capacità di lettura e di soluzione dei
problemi da parte dei quindicenni, collocano l'Italia ai livelli più bassi
della classifica. Tra 57 Paesi siamo al trentatreesimo posto in lettura, al
trentaseiesimo in cultura scientifica, al trentottesimo in matematica. Peggio di
noi in Europa sono solo Grecia, Portogallo, Bulgaria e Romania, mentre meglio di
noi Lituania e Slovenia. Negli ultimi sei anni siamo scivolati ancora più in
basso.
Vorrei però sottolineare preliminarmente come i risultati cambino sia riguardo
alla tipologia di scuola - meglio i licei, peggio gli istituti tecnici
professionali - sia rispetto all'area geografica - meglio il nord, peggio il sud
e le isole - sia all'interno di ciascuna area, con una distribuzione di
emergenze e di eccellenza a macchia di leopardo.
Va anche sottolineato che, se tutti i commentatori hanno fermato la propria
attenzione sui dati preoccupanti dei quindicenni, ben pochi hanno parlato delle
scuole elementari, che mantengono invece un livello di eccellenza. Lo studio IEA
PIRS pone i nostri bambini di 9 anni all'ottavo posto al mondo come capacità di
lettura, secondi in Europa solo a Russia e Lussemburgo. Ritengo opportuno
evitare di cercare soluzioni indifferenziate, giacché trattare malattie diverse
con la stessa cura non è certamente un approccio razionale.
Premesso il quadro nazionale unitario, cui siamo chiamati dai princìpi espressi
dall'articolo 117 della Costituzione, occorre superare una vecchia e deleteria
logica centralistica, che non tiene conto delle specificità sociali e
territoriali. Il nuovo ruolo delle regioni, sancito dal Titolo V della Carta
costituzionale e da definire compiutamente nell'attuazione della legge n. 53,
così come il necessario rafforzamento dell'autonomia scolastica, devono costituire una sorta di
federalismo all'insegna della sussidiarietà, che rappresenta il quadro
istituzionale entro cui affrontare i problemi.
Dobbiamo adottare la miglior cura per chi è più malato. Se siamo tutti
convinti che l'istruzione è storicamente la più formidabile leva di
emancipazione e di riscatto sociale, è ancora più urgente riparare questa leva
nel Mezzogiorno d'Italia, dove i bassi livelli di apprendimento, la povertà e
il degrado sociale rappresentano un male da estirpare. Quasi centocinquanta anni
di studi e interventi dei grandi meridionalisti, sin dalle prime indagini di
Sonnino e Franchetti, ci insegnano che solo attraverso il riscatto del
Mezzogiorno e il dispiegamento delle sue enormi potenzialità l'Italia potrà
considerarsi pienamente nazione.
A fronte di questi dati serve, a mio modo di vedere, uno scatto d'orgoglio
nazionale. Ciascuno di noi è chiamato a reagire e a togliere quel velo di
rassegnazione che troppo spesso accompagna l'analisi del sistema scolastico. Dai
posti più bassi delle classifiche l'Italia può e deve risalire. Non possiamo
rassegnarci, inoltre, di fronte al dato preoccupante della dispersione
scolastica. È un dovere cui siamo chiamati non solo dal Protocollo di Lisbona,
ma anche dalla necessità di garantire alle nuove generazioni tutti gli
strumenti atti ad affrontare il futuro. Due milioni di studenti delle scuole
superiori (oltre il 70 per cento) riportano una o più insufficienze al termine
del primo quadrimestre, negli istituti professionali gli insufficienti sono ben
8 su 10, mentre duecentomila studenti delle superiori nel corso del quinquennio
abbandonano la scuola o vengono bocciati.
In una scuola in cui, per riconoscimento unanime, seri e rigorosi criteri
selettivi sono venuti scemando e in cui si registra un'enorme dispersione di
capitale umano, o meglio di persone in carne ed ossa che vedono il proprio
futuro pregiudicato, occorre una presa di posizione lontana da inutili visioni
ideologiche. Il Paese ci chiede a gran voce di lasciare lo scontro politico
fuori dalla scuola. Non basta elevare sulla carta l'obbligo scolastico ed è
negativa la scorciatoia di semplificare i processi di apprendimento. Nostro
compito è quello di offrire al Paese una scuola che ciascuno, secondo le
proprie propensioni individuali, consideri strumento utile e necessario. Credo
che sia giunta l'ora del buonsenso, del pragmatismo e delle soluzioni condivise.
Questo principio vale anche sul fronte degli insegnanti. Non possiamo ignorare
che lo stipendio medio di un professore di scuola secondaria superiore, dopo 15
anni di insegnamento, è pari a 27.500 euro lordi annui, tredicesima inclusa. In
Germania ne guadagnerebbe 20.000 in più, in Finlandia 16 .000 in più. La media
OCSE è superiore a 40.000 euro l'anno. Questa legislatura deve vedere uno
sforzo unanime nel far sì che gli stipendi degli insegnanti siano adeguati alla
media OCSE. Ma per fare questo le difficoltà sono molte ed è necessario
aggredire le cause delle iniquità del sistema, mediocre nell'erogazione dei
compensi, mediocre nei risultati, mediocre nelle speranze.
Una scuola ostaggio di rivendicazioni, più finalizzata allo scontro ideologico
che non al recupero dei compiti del sistema, ha prodotto un esito che credo né
i sindacati, né i partiti, né la società italiana tutta possano ritenere
sensato: stipendi da fame, tramonto della cultura del merito, tramonto del senso
della scuola.
È una sconfitta nazionale, cui tutti abbiamo il dovere di reagire invocando un
vero cambiamento e non presunte riforme. Per troppi anni abbiamo creduto tutti
che le riforme legislative potessero produrre una palingenesi del sistema educativo e abbiamo affidato all'approvazione
parlamentare di leggi di sistema la nostra speranza di migliorare la scuola.
Abbiamo investito le nostre energie sull'attività legislativa. Abbiamo discusso
troppo e troppo a lungo di cicli, di modelli pedagogici, di indirizzi, di
dottrine e di ideologie formative. Abbiamo imbullonato e sbullonato leggi e
decreti, badando più al colore politico che alla sostanza dei problemi. Oggi
dovremmo tutti renderci conto che abbiamo bisogno di buona amministrazione, di
buongoverno, di semplificazione e di chiarezza. Il ministro prende qui l'impegno
solenne di rispettare queste considerazioni.
Proporrò modifiche legislative solo laddove sia strettamente necessario;
cercherò di contenere l'irresistibile tendenza burocratica a produrre montagne
di regolamentazione confusa e incomprensibile, di favorire l'adozione di criteri
generali e indicazioni nazionali leggibili, evitando la metastasi delle norme di
dettaglio. Soprattutto cercherò di preservare e di mettere a sistema quanto di
buono fatto dai miei predecessori. Per questo motivo non ho avuto tentennamenti
rispetto alla cosiddetta «circolare Fioroni» sul recupero dei debiti
scolastici attraverso prove supplementari. Nonostante il suo ritiro mi fosse
chiesto da più parti - e mi avrebbe certamente garantito una facile popolarità
- ho preferito rischiare di essere impopolare piuttosto che antipopolare. Ho
provveduto certo a modificare aspetti che mi sembravano troppo dirigistici, ma
non ne ho cambiato la sostanza. Questi anni hanno dimostrato che non c'è
alternativa possibile e praticabile al ritorno della scuola dell'impegno e del
rigore.
Per troppi anni la scuola, come altre istituzioni, è stata amministrata con una
visione ribaltata rispetto alla logica e al buonsenso. Si è pensato che
l'abbassamento della qualità potesse agevolare gli studenti offrendo agli
insegnanti qualche garanzia in più in grado di compensare la
perdita di ruolo e di status, con il risultato di non favorire né gli
uni né gli altri. La scuola ha smesso di essere un servizio ai cittadini e alla
nazione per diventare un enorme ammortizzatore sociale. Non c'è Paese al mondo
che abbia fatto così. Non ci sarebbe organizzazione in grado di sopravvivere a
queste procedure. È ingiusto per gli studenti e per i docenti, è soprattutto
mortale per la qualità del sistema educativo.
Accanto a questo criterio autodistruttivo ne abbiamo introdotto un altro, che ha
mortificato il senso di responsabilità. Abbiamo livellato le retribuzioni verso
il basso e quindi - verrebbe da dire - toccato il fondo. Nella scuola abbiamo
troppi dipendenti e poco pagati, con una carriera pressoché piatta. Non c'è
quindi da stupirsi se tantissimi bravi maestri e professori non si sentono
motivati, se tantissimi giovani preparati, con la vocazione all'insegnamento,
scelgono altre strade; se lo Stato dà poco, non potrà che chiedere poco, in
una spirale di frustrazione inarrestabile.
Dobbiamo trovare il modo di rovesciare questi criteri. La rivalutazione del
ruolo dei docenti, a partire dal pieno riconoscimento del loro status
professionale, che non può essere confuso con chi nella scuola ricopre altri
ruoli, ancorché essenziali, è un nodo da sciogliere. Affermo questo
ringraziando tutti quegli straordinari insegnanti, quegli eccezionali dirigenti
scolastici, i membri del personale amministrativo, che non solo svolgono il
proprio dovere, ma nonostante tutto vanno ben oltre. Abbiamo delle eccellenze da
cui desidero imparare, andando non a fare visite rituali, ma vivendo la scuola
con loro.
Dobbiamo trovare insieme il modo di migliorare le prestazioni della scuola, la
retribuzione degli insegnanti e la qualità dei servizi accessori, sapendo che
non disponiamo di risorse economiche illimitate, e che, anzi,
dobbiamo compiere un grande sforzo di riqualificazione della spesa pubblica. Il
precedente Governo aveva avviato un piano triennale di contenimento della spesa
pubblica nel settore della scuola, che abbiamo ereditato e rispetto al quale non
possiamo che procedere. I conti dello Stato e la situazione economica
internazionale lo impongono. Va anche detto, tuttavia, che la coperta è corta,
ma che la scuola è una priorità, anzi «la priorità». Non si tratta di un
capitolo di bilancio qualsiasi, perché da essa dipende il futuro del Paese e il
Governo dovrà tenerne conto.
Se vogliamo migliorare concretamente il sistema scolastico in Italia, non si può
eludere il tema dell'autonomia e dell'assunzione di responsabilità a tutti i
livelli. Parlare di autonomia significa innanzitutto valorizzare le governance
degli istituti, dotarle di poteri e di risorse adeguate e puntare alla loro
valutazione. Autonomia e valutazione sono due facce della stessa medaglia: non
possiamo rendere piena l'autonomia scolastica senza un sistema di valutazione
che certifichi in trasparenza come e con quali risultati venga speso il pubblico
denaro.
Roger Abravanel in Meritocrazia definisce l'Italia un Paese pietrificato
e come tale destinato al declino, precisando la sua idea di merito, che
condivido pienamente. Meritocrazia è un sistema di valori che promuove
l'eccellenza delle persone, indipendentemente dalla loro provenienza sociale,
etnica, politica ed economica. Il merito non è una fonte di disuguaglianza, ma,
al contrario, uno strumento per garantire pari opportunità ed è, dunque, la più
alta forma di democrazia. Secondo Abravanel l'equazione del merito è «intelligenza
più impegno. La scuola e l'università devono premiare gli studenti migliori.
Se i risultati sono uguali per tutti, saranno sempre i figli dei privilegiati a prevalere». Ritengo
che il punto di approdo del merito sia rappresentato dalla valutazione oggettiva
degli studenti, degli insegnanti e delle scuole, che deve riguardare, scuola per
scuola, non la presunta qualità dei processi e delle strutture, ma misurare il
risultato dell'azione educativa sul singolo ragazzo quanto a valore aggiunto di
cognizioni e crescita rispetto all'ingresso. Deve altresì tenere conto della
dispersione scolastica. Serve un cambiamento epocale di mentalità, ma la società
è pronta e se lo aspetta. Non sarà semplice e non sarà immediato, ma desidero
dare il mio contributo per spargere i semi dal merito. Germoglieranno, ne sono
sicura, perché l'Italia è pronta.
Se condividiamo il valore della valutazione, questa legislatura deve dare
stabilmente all'Italia un sistema avanzato e riconosciuto. Se condividiamo il
ruolo delle autonomie scolastiche, non solo a parole, ma nei fatti, sarà più
facile liberare le loro potenzialità.
Ritengo fuorviante in questo senso parlare di parità scolastica marcando la
diversità degli istituti scolastici in statali e privati. Si dice paritaria e
paradossalmente con ciò si finisce per allargare il solco. Con la legge n. 62
del 2000, varata otto anni fa da un Governo di centrosinistra, esiste oggi in
Italia un sistema pubblico di istruzione in cui convivono, in piena osservanza
costituzionale, scuole dello Stato e scuole paritarie, istituite e gestite da
privati. Tutte svolgono un servizio pubblico, in quanto tenute a rispondere a
precise indicazioni ordinamentali stabilite dal sistema legislativo.
Le scuole statali servono oltre il 90 per cento dell'utenza e sono quindi una
realtà estremamente ampia, importante e capillarmente diffusa su tutto il
territorio nazionale. D'altra parte, sta crescendo in tante zone d'Italia la
domanda delle famiglie per percorsi educativi con specifiche connotazioni, cui la scuola paritaria può fornire risposte
adeguate. Un sistema pubblico d'istruzione, che fondi sul principio di
sussidiarietà forme di pluralismo educativo, è la risposta alle esigenze di
istruzione e di formazione del cittadino.
L'affermazione della parità scolastica sarebbe un espediente retorico, se si
lasciassero languire o morire valide esperienze educative. Oltretutto, un
dossier dell'AGESC rivela che il risparmio per l'erario, determinato nell'anno
corrente dall'esistenza di queste libere iniziative, è di circa 5,5 miliardi, a
fronte di un contributo di circa 500 milioni di euro. Invito tutti a pensare non
agli istituti, ma agli studenti e alle loro famiglie. Ritengo infatti che tutte
le famiglie meritino di poter liberamente scegliere dove far educare i propri
figli.
Le risposte finanziarie fin qui sperimentate costituiscono un valido punto di
partenza per individuare forme efficaci di sostegno alle famiglie. Le scelte che
il Governo farà in proposito avranno tutto lo spazio del dibattito
parlamentare, per arrivare ad un sistema equo e condiviso. In questo senso, sarà
interessante valutare non solo le soluzioni messe a punto dai Governi nazionali
succedutisi, ma anche le strategie promosse dai governi regionali più sensibili
alla soluzione del problema.
Per quanto riguarda la condivisione degli obiettivi, al di là dei singoli temi
e capitoli, occorre percorrere la strada del cambiamento condiviso, per dare
stabilità al sistema. Solo condividendo la necessità di cambiare e rifuggendo
da logiche conservative si entra in sintonia con larga parte del corpo sociale e
si garantisce un senso al nostro ruolo. Quattordici associazioni di genitori, di
dirigenti scolastici e di docenti hanno recentemente promosso un
manifesto-appello, che chiede la condivisione di obiettivi che vanno dalla
libertà di scelta educativa alla piena attuazione dell'autonomia scolastica, dalla personalizzazione dei piani di studio
alla rivalutazione del ruolo del corpo docente. Altre spinte nella medesima
direzione provengono dal mondo della scuola, dell'imprenditoria, dagli enti
locali e dalle regioni, altre ancora dall'indagine conoscitiva condotta nella
precedente legislatura dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal
Ministero dell'istruzione, i cui esiti sono stati raccolti e analizzati nel
Libro bianco sulla scuola del settembre 2007.
Autonomia, valutazione e merito sono i grandi temi sui cui il Paese aspetta una
risposta, in primo luogo dalla sottoscritta, e su cui il Parlamento ha il
diritto e il dovere di esprimere la propria potestà legislativa. Mi sembra di
poter registrare una convergenza anche con l'opposizione sulla necessità di
avviare, citando dal programma del Partito democratico «una vera e propria
carriera professionale degli insegnanti che valorizzi il merito e l'impegno» e
ancora «nel realizzare un nuovo salto nell'autonomia degli istituti scolastici,
facendo leva sulle capacità manageriali dei loro dirigenti all'interno di
organi di governo aperti al contesto sociale e territoriale sulla valutazione
sistematica dei risultati». Celebrando la Costituzione italiana, il mio
predecessore, onorevole Fioroni, parlava di questa come della possibile
legislatura del buonsenso. Condivido le sue parole.
Se esiste un campo in cui il buonsenso e la politica devono incontrarsi, questo
è proprio quello della scuola. Proprio sotto l'egida del buonsenso, mi sembra
si sia avviato il confronto con Maria Pia Garavaglia in qualità di ministro
ombra dell'istruzione, che ringrazio, più ancora che per le parole di stima che
ha voluto rivolgermi, per essere da subito entrata senza preclusioni nel merito
dei primi atti compiuti dal mio dicastero.
Oggi dobbiamo interrogarci anche su cosa chiediamo alla scuola. La risposta
potrebbe apparire scontata, ma in realtà non lo è. Pochi si aspettano dalla
scuola che fornisca conoscenze disciplinari, formazione culturale, formazione
professionale ed educazione. Non se lo aspettano molti, troppi studenti. Non è
un caso se abbiamo portato al 93 per cento il tasso di partecipazione
all'istruzione secondaria superiore della fascia dei giovani tra i 15 e i 19
anni.
Nel 2006, un giovane su cinque tra i 18 e 24 anni aveva abbandonato
prematuramente gli studi senza acquisire un diploma di scuola superiore o almeno
una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età. Possiamo tendere
a raggiungere gli obiettivi di Lisbona solo se a quei giovani e a quelle
famiglie riusciamo a dimostrare e non a dire che in quel diploma e in quella
qualifica risiede non un pezzo di carta, ma un futuro migliore.
Oggi i dati statistici indicano che la società italiana è immobile. Il figlio
dell'operaio è drammaticamente condannato, se è fortunato, a fare l'operaio.
Ditemi voi se questo può essere ritenuto un sistema equo.
Antonio Gramsci asseriva che il merito e la fatica dello studio sono gli unici
possibili fattori di promozione sociale. È una citazione dai Quaderni dal
carcere, che voglio ricordare prima di tutto a me stessa. Gramsci scriveva:
«Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto
faticoso, con un suo speciale tirocinio. È un processo di adattamento. È un
abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza». La
partecipazione di più larghe masse alla scuola media porta con sé la tendenza
a rallentare la disciplina dello studio e a domandare facilitazioni. Occorrerà
resistere alla tendenza di rendere facile ciò che non può esserlo senza essere
snaturato.
Abbiamo di fronte a noi un'occasione: il precedente Governo ha stabilito, di
concerto con le regioni, di rinviare al 1o settembre 2009 l'entrata a
regime della legge n. 53. Il tempo è poco, ma il Parlamento e tutti gli attori
coinvolti hanno la possibilità di dare al Paese una straordinaria prova di
produttività. Ci sono due pilastri da rafforzare: il primo riguarda il nocciolo
dell'istruzione, il secondo riguarda la personalizzazione dell'istruzione.
Lo Stato è chiamato dalla Costituzione a determinare i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale e a dettare le norme generali sull'istruzione.
I livelli essenziali nella società della conoscenza non possono che essere
costituiti da una formidabile preparazione di base, che oggi è venuta
drammaticamente a mancare.
La patente delle tre «I» - inglese, internet e impresa -, indispensabile a
percorrere le strade del terzo millennio, non può essere presa a discapito
della quarta «I», quella di italiano, termine con cui ricomprendo l'antico
trinomio «leggere, scrivere e fare di conto», da declinare e approfondire a
seconda dei livelli e dei percorsi di istruzione, senza indulgere nello
spezzettamento dei saperi e nei «progettifici», che, come segnalato dai moniti
internazionali e dai documenti elaborati dal precedente Governo, producono nei
nostri studenti inevitabili corto circuiti e deficit nella conoscenza,
impossibili da recuperare.
Come fa dire Leonardo Sciascia al professore Carmelo Franzò «l'italiano non è
l'italiano, è il ragionare». L'italiano è quindi il territorio in cui si
esercita la ragione, la ricerca del senso, la matematica e infine le tre «I»,
che fioriscono bene solo in questo alveo di significato.
Le indicazioni nazionali saranno concentrate su questo obiettivo, lasciando alle
autonomie scolastiche le più ampie possibilità, nella parti a loro riservate,
di esaltare le proprie specificità, sempre - mi auguro - con l'obiettivo
dell'eccellenza.
Si sarà notato che uso spesso la parola «eccellenza» e che non cerco
sinonimi, perché lo scopo che con voi vorrei pormi è il seguente ossimoro: «la
normalità dell'eccellenza». Non è un paradosso, ma l'attenzione che anima
ogni educatore.
Quanto alla personalizzazione dell'istruzione, non intendo riassumere un
dibattito troppo vasto e troppo ben conosciuto dai presenti, la cui leva
principale è nell'interazione, nella sinergia tra autonomie scolastiche,
docenti, studenti e famiglie. Al mondo non esiste legge o circolare ministeriale
che possa indicare come e quando personalizzare. Esistono invece quadri di
riferimento in grado di aiutare i soggetti della personalizzazione a parlare tra
di loro e ad individuare le soluzioni concrete. Servono uno sforzo innanzitutto
umano e il cuore dell'educatore che personalizzi l'istruzione.
Mi concentro ora, seppur per sommi capi, sulla scuola secondaria di secondo
grado, sul sistema dei licei, degli istituti tecnici e professionali, sulla
formazione professionale. Ho ereditato materiali utilissimi, come il rapporto
della cosiddetta «Commissione De Toni» sull'istruzione tecnica e
professionale, che ci consentono di non iniziare ancora una volta da capo.
La mia prospettiva - spero la nostra prospettiva - è quella di portare tutto il
sistema in serie A. Ogni pezzo del sistema deve avere pari dignità, perché
ogni persona deve avere gli strumenti atti ad edificare il proprio progetto di
vita.
Vorrei che il dibattito sulla cosiddetta «scelta precoce» si trasformasse
nella costruzione dei percorsi più adeguati per permettere ad ogni ragazzo di
trovare la propria strada. Il substrato di quel dibattito, magari sottaciuto,
è permeato da una concezione classista, per cui il liceo è di serie A,
l'istruzione professionale e tecnica sono di serie B, il sistema regionale delle
qualifiche è di serie C. Non è così, o meglio, non è scontato che debba
essere così. Non è così per gli istituti tecnici, ad esempio, da cui proviene
- mi limito a citare un dato - lo zoccolo duro dei nostri laureati in
ingegneria. Mi rifiuto, inoltre, di considerare il sistema della formazione
professionale come una sorta di suburra, in cui relegare forzosamente sui banchi
adolescenti per così dire difficili.
Alcune regioni hanno costruito un sistema di grande qualità, che offre
prospettive ai giovani e garantisce al mondo del lavoro persone preparate e
predisposte alla formazione permanente. L'indifferenziazione dei percorsi, la
pretesa di uccidere le propensioni individuali per pretendere ope legis
che ogni adolescente percorra la stessa strada sono la traiettoria più sicura
verso gli abbandoni e la dispersione. Diamo ad ogni persona la sua scuola e ogni
persona troverà nella sua scuola le ragioni per frequentarla con profitto.
Ridare senso alla scuola significa ridare senso a ciascuno dei percorsi per gli
studenti e per le loro famiglie, ridare una motivazione per ciascuno a stare sui
banchi, per stare meglio nella vita. Alcune di queste motivazioni possono essere
rintracciate nella permeabilità tra mondo della scuola e mondo del lavoro.
Alcune delle eccellenze nei settori dell'istruzione tecnica e della formazione
professionale si fondano su questo interscambio, ma non credo che il sistema dei
licei debba essere considerato una turris eburnea, tutt'altro.
L'interazione tra scuola e lavoro, tra scuola e vita reale ha un ruolo
inestimabile: far comprendere allo studente, in un'età difficile, l'utilità
concreta di quanto sta facendo, che imparare serve ad essere promosso non solo a
scuola, ma anche nella vita.
Nello spirito di una scuola che sia realmente per tutti, affermo il diritto
all'istruzione di chi presenta abilità diverse. Gli obiettivi didattici, le
metodologie e gli strumenti devono essere personalizzati e coerenti con le
abilità di ciascuno, per definire i livelli di apprendimento attesi. Molte sono
le buone pratiche costruite su competenza, professionalità, disponibilità e
impegno delle diverse componenti scolastiche, dagli insegnanti di sostegno agli
insegnanti curriculari, dai dirigenti scolastici alle associazioni. Occorre fare
tesoro dell'esperienza. Il mio impegno è indirizzato ad ascoltare le esigenze,
le criticità, le proposte delle famiglie e di tutte quelle realtà associative
che si occupano di disabilità, al fine di individuare insieme anche percorsi
formativi più adeguati al bisogno con la necessaria flessibilità, superando le
rigidità non coerenti con l'azione educativa.
La scuola coinvolge la responsabilità dell'intera società, a cominciare dalle
famiglie e dagli insegnanti. Elevare la qualità della scuola richiede
un'assunzione di responsabilità collettiva. I fallimenti sperimentati nella
quotidianità con i gravi fatti di violenza, di bullismo, di tossicodipendenza
rendono consapevoli insegnanti e famiglie dell'impossibilità di farcela da
soli, ciascuno per proprio conto, e della necessità di una cooperazione
corresponsabile tra tutti i protagonisti del processo di crescita umana e
professionale dei giovani.
Se avvicineremo famiglia, scuola, comunità civile e mondo del volontariato, con
il suo patrimonio di valori vissuti e di conoscenza del prossimo, e li faremo
convergere su un'attenzione disinteressata nei riguardi dei giovani, sarà
possibile far fronte alla sfida dell'emergenza educativa. Solo una partnership
tra scuola e famiglia è in grado di affrontare disagi e difficoltà e di
perseguire la qualità nei rapporti e negli apprendimenti, in modo che ogni studente possa
trovare nella scuola le condizioni per valorizzare le proprie capacità e
realizzare il proprio progetto di vita.
Difficoltà di apprendimento, scarso rendimento scolastico, abbandono degli
studi, inconsapevolezza delle regole, abuso di sostanze stupefacenti si trovano
alla base di fenomeni antisociali, quali la micro delinquenza e il bullismo e si
manifestano sempre più precocemente. Va anche osservato che troppo a lungo si
sono delegate alla scuola responsabilità e azioni che competono alla famiglia,
che, pur nelle sue difficoltà, rappresenta la base fondamentale su cui
sviluppare le attività didattiche, formative ed educative.
In questi ultimi anni, in particolare, la crisi della famiglia rende ancora più
complesso il compito della scuola. Il manifestarsi delle diverse forme di
disagio, infatti, chiama in causa innanzitutto gli affetti, i sentimenti, la
vita di relazione dei giovani. Se si vuole rispondere efficacemente alla
profonda esigenza di trasmettere il valore del rispetto e dell'osservanza delle
regole, il valore della legalità, dei diritti e dei doveri, occorre agire sin
dai primi anni di vita, sin dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria.
Veniamo al tema dell'integrazione, una parole chiave: integrazione nella comunità,
nella civitas. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla spinta
migratoria, che coinvolge centinaia di migliaia di adulti e centinaia di
migliaia di bambini. Il nostro primo obbligo è insegnare a tutti loro la lingua
italiana e la Costituzione della Repubblica.
Non sono passati secoli, ma pochi lustri, da quando un'altra spinta migratoria
all'interno del Paese è stata l'occasione per alfabetizzare centinaia di
migliaia di italiani, che sono diventati l'ossatura della nostra industria e gli
artefici, con la doppia fatica dello studio e del lavoro, del miracoloso boom
economico italiano. Oggi dobbiamo garantire la stessa
alfabetizzazione agli immigrati e ai loro figli, per loro e per i nostri figli.
In numerose classi il processo di apprendimento è frenato dalla necessità di
non lasciare indietro, di non escludere quote sempre più alte di alunni
extracomunitari, ragazzi e ragazze con competenze proprie, ma penalizzati dalla
barriera linguistica.
Occorre trovare soluzioni atte ad abbattere questa barriera e concentrare su
quelle le nostre risorse professionali ed economiche, uscire dalle
sperimentazioni per entrare nella normalità. Sulle modalità vorrei che si
esprimesse la Commissione, ma chiederò anche l'aiuto di chi si trova in prima
linea ad affrontare il problema, a partire dagli insegnanti delle classi in cui
il numero di studenti stranieri è più elevato.
Alfabetizzazione significa anche alfabetizzazione civile per i figli degli
extracomunitari, che devono apprendere le regole della comunità italiana, così
come noi apprendiamo e applichiamo le regole delle case in cui veniamo ospitati,
ma anche per i giovani italiani. Giusto cinquanta anni fa, un grande statista e
Ministro della pubblica istruzione, Aldo Moro, introduceva nelle scuole lo
studio dell'educazione civica. Mi sembra che potremmo celebrare degnamente
questo cinquantenario e i sessanta anni dalla nascita della Costituzione
restituendo un ruolo centrale all'educazione civica.
Signor presidente, onorevoli deputati, mi avvio ormai a concludere. Prima delle
elezioni, un gruppo di volenterosi uomini di conoscenza, il cosiddetto «gruppo
di Firenze», si è riunito per proporre agli italiani e in particolare alle
forze politiche un manifesto-appello. Vorrei farlo mio e impossessarmi del suo
messaggio più importante, laddove recita: «Sia le riforme sia il Governo e la
vita della scuola, a tutti i livelli, dovranno ispirarsi ai criteri di merito e
di responsabilità.
L'aggiornamento dei programmi, la
riorganizzazione dell'istruzione superiore, l'autonomia delle scuole potranno
dare risultati effettivi e duraturi solo recuperando e mettendo in pratica
questi elementari princìpi dell'etica pubblica e privata. Dobbiamo offrire ai
nostri ragazzi una scuola più qualificata ed efficace, ma insieme più esigente
sul piano dei risultati e del comportamento. Dobbiamo restituire ai docenti,
spesso demotivati e resi scettici da troppe frustrazioni, il prestigio e
l'autorevolezza del loro ruolo, intervenendo, però, con tempestività e rigore
nei casi - pochi, ma negativi per l'immagine della scuola - di palese negligenza
o di inadeguatezza. I dirigenti scolastici, infine, andranno valutati in primo
luogo per la loro capacità di garantire nel proprio istituto professionalità e
rispetto delle regole da parte di tutti».
Desidero rivolgermi ai firmatari di questo appello, chiedendo loro aiuto. Sono
infatti convinta che invertire la tendenza al degrado della scuola richieda un
grande sforzo nazionale, cui sono chiamati il Parlamento e le parti sociali
nelle loro definite responsabilità, cui è partecipe il mondo della cultura, il
mondo dei giovani e le loro famiglie. Abbiamo bisogno di una grande alleanza per
la scuola, che restituisca al Paese la parola «speranza».
A chi ha sottoscritto quel documento, ai tanti che in queste settimane mi hanno
dato utilissimi consigli chiedo collaborazione, così come anche alle
associazioni degli studenti. Recentemente, ho incontrato il loro forum e so che
non sarà facile trovare una lingua comune, perché spesso sono stati dati per
scontati una sostanziale incomunicabilità e un atteggiamento in cui ministro e
rappresentanti degli studenti sono controparti. Non lo do per scontato e chiedo
loro di non darlo per scontato, prendendo l'impegno di tenere aperto un canale non episodico di discussione. Su alcuni punti
avremo probabilmente posizioni diverse, ma ci saremo parlati e confrontati.
La scuola ha bisogno di un grande impegno civile. Non dobbiamo rassegnarci e
credere che la scuola italiana sia un malato terminale, ma è necessario uno
scatto di orgoglio da parte di tutti. Personalmente ci credo, sono ottimista e
intendo spendermi fino in fondo. Vi chiedo collaborazione e aiuto in questo
sforzo di ricostruzione della principale infrastruttura italiana. Grazie. (Applausi).
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200806/0610/html/07/
Camera 17 giugno 2008
MARIASTELLA GELMINI, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Signor presidente, onorevoli deputati, siamo
giunti alla seconda parte di quella duplice fatica cui facevo riferimento nel
mio primo intervento di fronte alla Commissione. Cambiano, oggi, le materie
trattate, ma non cambiano i cardini del ragionamento che ho precedentemente
condiviso con voi. Istruzione, università e ricerca scientifica sono moduli
distinti, ma rappresentano, insieme, l'infrastruttura del sapere e, come ogni
infrastruttura, vincono solo se interconnessi l'uno all'altro.
La sfida decisiva del capitale umano e dell'innovazione si gioca a questo
tavolo. Occorre riconoscere, innanzitutto, che l'università e la ricerca sono
fattori indispensabili di sviluppo della nostra comunità nazionale. Eliminarne
le criticità è quindi strategico.
A questo proposito occorre ricordare che nel recente passato il nostro sistema
formativo era in grado di formare capitale umano di eccellenza. La domanda è la
seguente: come è possibile recuperare questa capacità nell'attuale contesto
sociale ed economico complesso e globalizzato?
Si prospettano due possibilità. Una gestione più fortemente centralizzata del
sistema universitario, con regole uguali per ogni
ateneo, ogni professore, ogni ricercatore; oppure, prendendo atto delle diversità
presenti tra i singoli atenei e centri di ricerca, porre le condizioni per
valorizzarne la specificità. La seconda opzione, analogamente a quanto avviene
in molti Paesi caratterizzati da sistemi universitari di eccellenza, ci sembra
quella da sostenere.
Siamo chiamati, come istituzioni politiche e come società, ad un comune commitment
per l'università e la ricerca, riconoscendone il ruolo primario per la
formazione della classe dirigente, come fa ogni grande Paese moderno. La
filosofia cui intendo informare l'azione del Ministero, per questi motivi, non
cambia. Si fonda sul trinomio autonomia, valutazione, merito, che è quanto
l'Italia, oggi, si aspetta da noi.
Vorrei, prima di tracciare un quadro generale della situazione e formulare
alcune prime proposte, aggiungere altre due considerazioni. La prima, riguarda
la leva legislativa, la seconda il ruolo dei giovani. Nel corso di questi ultimi
anni si sono venute stratificando una serie di norme, a volte contraddittorie, a
volte di difficile interpretazione, che hanno di volta in volta interrotto e
contraddetto ipotesi di riforma, anche coraggiose, proposte dai ministri che si
sono via via succeduti, a partire da Antonio Ruberti, cui va il mio commosso
ricordo, per finire con Letizia Moratti, autrice di una proposta capace di
intervenire su alcuni snodi fondamentali. Il mio impegno è quello di dotare,
entro il termine dei cinque anni di legislatura, il mondo dell'università e
della ricerca di regole certe e condivise, di testi unici che non siano la
sommatoria di norme già esistenti, ma, al contrario, eliminino «il troppo e il
vano» e liberino le ali dell'autonomia dal troppo piombo che ne impedisce il
volo. Né io né voi possiamo ovviamente
paragonarci a Giustiniano; tuttavia, l'esempio di una attività legislativa che
possa sfidare il futuro mi sembra ci debba essere caro.
Quanto al ruolo dei giovani, può sembrare pletorico ricordare quanto ricada su
di loro il vizio di una società italiana ancora troppo ingessata,
gerontocratica e refrattaria a riconoscere il merito. Si pensi che, in Italia,
solo il 15 per cento dei dirigenti, l'8 per cento dei professori associati e l'1
per cento dei professori ordinari ha meno di 40 anni. Vorrei che fossero proprio
i giovani ad aiutarci a progettare il futuro del Paese, che è in fondo,
soprattutto, il loro futuro. Mi propongo di invitare al Ministero i giovani
docenti e ricercatori per partecipare a un grande concorso di idee, e quindi per
potermi aiutare a rendere realtà le idee migliori, a tradurle in pratica e a
proporvele. Ho intenzione di spalancare le porte dell'EUR a quest'aria nuova,
per investire davvero sui giovani talenti. È un dato di fatto che i risultati
del nostro lavoro saranno misurabili in un futuro non immediato. Mi sembra
giusto chiamare a progettarlo chi ne sarà protagonista.
E veniamo al quadro d'insieme. Ho incontrato nei primi giorni di questo mio
mandato, un numero notevole di persone e rappresentanti di istituti di
eccellenza su cui l'Italia può certamente contare. Ma sappiamo tutti che il
sistema dell'università e della ricerca presenta, accanto a situazioni che
gareggiano alla pari con le migliori realtà estere, un quadro non confortante.
Nelle classifiche internazionali, i nostri atenei arrancano. Studenti,
ricercatori e docenti provenienti dall'estero sono decisamente troppo pochi: e
un'ottima università si distingue anche per un ambiente culturale
internazionale.
La pronta adesione al «processo di Bologna» e la conseguente introduzione del
«3+2», se ci ha consentito di aumentare il numero dei laureati, è messa da più
parti sotto accusa per aver innescato un processo di licealizzazione prolungata
e una proliferazione di corsi e indirizzi
che non ha eguali negli altri paesi europei: 3.200 corsi in Italia, contro gli
800 della Germania. Sul «3+2» intendo, peraltro, proseguire una rigorosa
attività di monitoraggio e continuare sulla strada intrapresa dai miei
predecessori verso una forte razionalizzazione dei corsi.
Va anche rilevato che la formazione post laurea di terzo e quarto livello,
troppo spesso diviene una sorta di area di parcheggio da cui pescare mano
d'opera accademica a basso costo. Inoltre, l'FFO è basato in larghissima parte
sullo «storico» e alimenta bilanci ingessati, senza che una percentuale
significativa delle risorse sia destinata a premiare il merito e l'eccellenza.
Manca, inoltre, un collegamento stretto con il mondo del lavoro che dovrebbe
caratterizzare molto più di quanto oggi avvenga le lauree triennali; si
registra una scarsa valorizzazione delle forme di apprendistato
professionalizzante finalizzato a garantire uno sbocco che sfrutti le competenze
maturate. E non si può sottacere che, mentre gli iscritti ai corsi di laurea
umanistici e di comunicazione sono migliaia, si rileva tuttora una scarsa
percentuale di iscrizione ai corsi di laurea scientifici. Fin qui la fotografia
dell'esistente. A noi il compito di trovare soluzioni adeguate per rilanciare la
qualità degli studi e l'università.
E veniamo alle risorse. È un dato di fatto che la ricerca sia sottofinanziata.
La percentuale di investimento in ricerca è in Italia pari all'1,09 per cento
rispetto al PIL contro una media OCSE del 2,26 per cento. La percentuale di
incremento annuo è del 2,70 per cento, in Grecia è del 16,70 per cento, in
Estonia del 13 per cento. Con queste cifre, capite bene che è difficilissimo
competere, se non impossibile. Sarebbe suicida mantenere un'arretratezza così
evidente nell'investimento più utile per la crescita di una nazione e per la
promozione sociale. Si pensi che delle 20
migliori università, per risultati di ricerca e didattica, 17 sono negli Stati
Uniti. E gli Stati Uniti sono il Paese con il più alto tasso di mobilità
sociale.
Se da un lato dobbiamo fissare l'obiettivo di aumentare le risorse a
disposizione, occorre, però, da subito, imparare a spenderle meglio,
vincolandole alla responsabilità, ai risultati conseguiti ed eliminando sacche
di spreco o di spesa poco produttiva. Possiamo chiedere al Paese uno sforzo
finanziario aggiuntivo soltanto se garantiremo un rinnovamento nel metodo di
spesa, vincolando cioè i finanziamenti al livello della didattica e della
ricerca, portando ad almeno il 20 per cento del fondo la quota destinata a
premiare i migliori. Più risorse e più meritocrazia saranno il nostro
indirizzo.
Sulla leva finanziaria ci sono due tipi diversi di interventi da fare, a seconda
della provenienza pubblica o privata dei fondi. Il primo intervento riguarda le
risorse pubbliche. Siamo, in questo caso, con lo 0,58 per cento, più o meno al
livello di altri paesi. Ma è inammissibile il ritardo con cui i bandi vengono
promulgati, inammissibile la lentezza con cui i risultati vengono valutati e il
tempo in cui i contributi vengono corrisposti. Erogare i fondi con mesi, se non
anni, di ritardo, significa uccidere il sistema. Ho intenzione, in tal senso, di
compiere uno sforzo prioritario per tagliare senza esitazione il cappio che
strangola l'opera di tanti ricercatori. Dobbiamo dare un esempio di burocrazia
efficiente. Può sembrare una contraddizione in termini, ma è essenziale fare
di tutto per realizzare un sistema di distribuzione delle risorse che sia
rapido, giusto ed equo.
Sul versante dell'investimento privato, le note sono invece in parte dolenti.
Non solo le grandi imprese, salvo rare eccezioni, investono poco, ma il tessuto
imprenditoriale italiano è caratterizzato, come sapete, da piccole e medie
imprese, le quali fanno fatica ad accantonare fondi da investire per la ricerca,
nonostante una grande propensione all'innovazione registrata dalle statistiche
che va assolutamente riconosciuta. Mi impegno a studiare, di concerto con i
colleghi di Governo, meccanismi di agevolazione per le piccole e medie imprese
che coordinino i loro investimenti. Crediti di imposta e defiscalizzazioni sono,
assieme all'unione delle forze - e penso anche al ruolo delle fondazioni
bancarie, per esempio, al ruolo del no-profit, delle associazioni di categoria -
la chiave per ridare risorse alla ricerca.
Ma il problema delle risorse riguarda anche le università, come ho
precedentemente accennato. Si è data autonomia, senza però chiedere conto dei
risultati. Sono troppi i casi di spesa senza controllo, di sforamento dei tetti
previsti riguardo, ad esempio, alla quota massima del 90 per cento degli FFO per
quanto riguarda il personale. Alcuni atenei, inoltre, versano in una situazione
di avanzata esposizione finanziaria. Siamo pronti ad aiutarli, secondo piani
pluriennali concordati di rientro dall'indebitamento, vincolandoli però
rigorosamente ad una gestione responsabile e virtuosa della spesa.
Non è mia intenzione limitare in alcun modo l'autonomia degli atenei, ma
desidero, insieme a loro, trovare soluzioni accettate e condivise, percorsi che
recuperino i casi di dissesto con tempi e risorse certe; fissare regole
altrettanto certe che consentano di liberare risorse per premiare la qualità.
Occorre mettere in atto un chiaro patto di stabilità, individualizzato per ogni
singolo ateneo, così da valorizzare le specificità.
E veniamo alla sfide. È mia intenzione, in questa relazione, affrontare solo
alcuni dei punti che riguardano le linee di Governo, rinviando a momenti
successivi l'approfondimento di altri punti.
Trovo che focalizzare la relazione su alcuni temi possa lasciare spazio maggiore
al dibattito e del resto il campo è talmente vasto da esigere una prima
selezione degli argomenti.
Dobbiamo affrontare con coraggio alcune sfide impellenti: l'autonomia e la
responsabilità, la valutazione, il reclutamento dei docenti, il welfare
studentesco, la governance, l'eccellenza e la riforma degli istituti di
ricerca.
Per quanto riguarda l'autonomia e la responsabilità, la prima considerazione da
fare è che il sistema dell'università e della ricerca si presenta estremamente
variegato: atenei di diversa propensione e dimensione, centri di ricerca
pubblici e privati, consorzi. Sarebbe fuorviante cercare di ridurre questo
patrimonio di diversità a un tutto unico. Dobbiamo cercare, invece, di fare
della diversità un punto di forza.
Senza dubbio l'autonomia ha un valore fondante, costitutivo e, direi quasi,
antropologico. La constitutio habita, primo statuto della prima università,
l'Alma Mater Studiorum di Bologna, concessa da Federico I nel 1158, giusto 950
anni fa, riconosce la libertà della ricerca e fa dell'università una libera societas
di allievi presieduta da un maestro. E la carta costituzionale richiama il tema
dell'autonomia: «Le istituzioni di alta cultura, - recita l'articolo 33
- università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». Non intendo, quindi, in alcun modo,
conculcare questa autonomia. Anzi, vorrei che insieme la rendessimo più piena,
a patto che la stessa autonomia diventi più responsabile.
In questi anni si è riconosciuta l'autonomia alle università, senza però
coniugarla con il richiamo alla responsabilità e alla valutazione delle scelte.
Responsabilità significa la possibilità di essere premiati o sanzionati per le
scelte, rispettivamente vincenti o
sconvenienti, che si sono operate. Richiamo il mondo dell'università a questa
sfida, che so essere da loro già avvertita come cruciale per il rilancio del
sistema.
Lavorerò per un sistema competitivo. Ma per chiarire cosa intendo per
competizione, voglio affidarmi alle parole di Dario Antiseri: «Quando noi
parliamo di competizione - dice Antiseri - spesso abbiamo paura di questa
parola, perché la competizione è guerra; tuttavia, il progresso scientifico si
ha perché la ricerca scientifica è una competizione serrata tra idee. Pensate
alla battaglia tra copernicani e tolemaici, tra arbitralisti e meccanicisti in
biologia. La scienza va avanti attraverso teorie e confutazioni, va avanti tra
proposte di teorie e critiche a queste teorie. Non è razionale colui che
difende la sua teoria ad ogni costo. (...). Quindi, è la competizione ad
animare la scienza, la democrazia e il mercato e chi non vuole la competizione
ha scelto di bloccare il mutamento. Del resto la parola cumpetere vuol
dire cercare insieme la soluzione migliore in modo agonistico».
In tal senso avanzo una prospettiva di lavoro: la natura pubblica del sistema
erogato non presuppone la natura statale dei soggetti erogatori. È un punto
acquisito anche dal dibattito sulla parità scolastica, che a maggior ragione
ritengo di proporre per l'università. Dunque, per un sistema che sia veramente
e virtuosamente competitivo, l'approdo da auspicare è la parità delle
condizioni finanziarie delle strutture pubbliche e private che rispettino, però,
alcuni severi requisiti, evitando di relegare l'iniziativa privata per lo più
in spazi residuali, destinati magari alla creazione di aree di eccellenza, ma
anche di privilegio sociale. Ovviamente non hanno spazio nella mia concezione
esempi di «esamifici» che possano spuntare, e che in parte sono spuntati,
verso i quali l'atteggiamento del Ministero sarà di assoluto rigore.
Per far questo, dobbiamo innanzitutto elevare i criteri di accreditamento delle
strutture universitarie, sulla base di alcuni parametri oggettivi e
certificabili, quali le esigenze del territorio, la capacità di
autofinanziamento, l'adeguatezza dei corsi di laurea rispetto agli obiettivi
formativi, la composizione del corpo docente, l'idoneità tecnica delle
strutture.
E veniamo alla valutazione che va, a mio modo di vedere, coniugata con la
trasparenza. Per poter premiare le università virtuose, secondo il principio
del merito e della responsabilità, ed incoraggiare quelle meno virtuose
all'adozione di politiche migliori, è necessario affrontare il problema della
valutazione. Anzitutto, occorre dire che intendiamo valutare i risultati più
che le procedure, come nello spirito della delivery unit concepita da
Tony Blair. La normativa in tema di valutazione è, nel nostro Paese, ancora in
uno stato di incertezza. Il precedente Governo ha istituito l'ANVUR - Agenzia
Nazionale di Valutazione - che dovrebbe sostituire il CNSVU - Comitato Nazionale
di Valutazione del sistema Universitario - e il CIVR. Ma l'ANVUR non può ancora
diventare operativa, per via dei rilievi che le sono stati mossi dal Consiglio
di Stato. Peraltro, la stessa Corte dei conti ne ha registrato con riserva il
regolamento.
L'ANVUR è stata concepita come una costosissima struttura ad alto tasso di
burocrazia e rigidità, destinata a controllare anche le procedure e i
meccanismi più piccoli,, caricata di eccessivi compiti che non potrebbe
svolgere se non in tempi molto lunghi e non è questo quello di cui abbiamo
bisogno. Occorre, dunque, rivedere la disciplina dell'ANVUR, al fine di
assicurare al mondo dell'università e della ricerca un sistema integrato di
valutazione, che vincoli il finanziamento ai risultati, incentivando l'efficacia
e l'efficienza dei programmi di innovazione e di ricerca, la qualità della
didattica, lo svolgimento dei corsi anche
in lingua inglese, la capacità di intercettare finanziamenti privati ed
europei, il tasso di occupazione dei laureati coerente col titolo di studio
conseguito.
In questo quadro di valutazione dobbiamo, però, preservare la specificità di
un sistema variegato. Alcuni criteri saranno applicabili a tutte le facoltà e
corsi di laurea, altri no. Esistono esperienze internazionali consolidate,
paradigmi riconosciuti dalla comunità scientifica. Ci riferiremo ad essi,
cercando la condivisione del mondo accademico. Tuttavia, nel frattempo non è
possibile lasciare né le università né gli enti di ricerca, destinatari di
finanziamenti pubblici, senza strumenti di valutazione, per cui è allo studio
una proroga degli organismi vigenti.
Inoltre, per la valutazione dei risultati didattici e di ricerca pensiamo ad un
doppio binario. Oltre alla doverosa valutazione da parte dell'Agenzia, occorre
incoraggiare quella forma di valutazione plurale, spontanea, quotidiana, che
viene operata dagli studenti e dalle famiglie ai fini della scelta
dell'università da frequentare, così come viene operata dalle imprese e dalle
fondazioni quando scelgono l'ateneo al quale indirizzare finanziamenti o
richieste di collaborazione.
Questa forma di «valutazione dal basso» è essenziale. Affinché essa sia
possibile, è necessario introdurre regole di trasparenza e di pubblicità. Le
singole università dovranno fornire sui loro siti web, come avviene in
gran parte del mondo anglosassone, i dati sugli sbocchi professionali dei loro
studenti, sulla produzione scientifica annuale dei loro docenti e ricercatori e
sulla customer satisfaction degli studenti, un monitoraggio che già
diversi atenei, statali e privati, peraltro, provvedono
a compiere. Sappiamo tutti che solo con la trasparenza e l'accessibilità alle
informazioni può affermarsi un sistema pienamente meritocratico.
Passiamo al tema del reclutamento. Non voglio neppure sottrarmi ad una prima
riflessione in merito anche perché nei prossimi cinque anni è previsto un
ricambio del 47 per cento del corpo docente. Le regole che stabiliamo ora sono
destinate ad influire sul sistema universitario per i prossimi venti anni e a
determinarne, almeno in parte, le sorti. Due sono le anomalie italiane: da una
lato, l'anzianità dei professori ordinari e associati; dall'altro lato, i
ricercatori sono pochi e inadeguatamente retribuiti. Entrambi questi dati
dovranno essere portati nei prossimi cinque anni almeno vicini alla media
europea.
Certamente dobbiamo prendere coscienza che non è possibile lasciare un'intera
generazione ai margini del sistema della ricerca e dell'università. Non
possiamo permetterci di rappresentare un'anomalia per il mondo industrializzato,
non possiamo permetterci un'università che favorisca le progressioni di
carriera locali piuttosto che l'ingresso di forze nuove. Inoltre, non possiamo
permetterci un sistema duplicemente impermeabile, rispetto ai giovani studiosi
italiani e rispetto agli studiosi stranieri.
L'area dei ricercatori e dei dottori di ricerca, quella dove si dovrebbe formare
il corpo accademico, è ristretta. A fronte di circa 38 mila professori, più o
meno equamente ripartiti tra ordinari e associati, ci sono 23 mila ricercatori:
il sistema è più simile a un cilindro che non ad una piramide. Quanto ai
dottori di ricerca, da noi ce ne sono circa 16 per ogni 100 mila abitanti,
contro i 50 della media europea. Sul fronte dei ricercatori nella finanziaria
del 2007 è stato previsto un finanziamento di 40 milioni di euro per il 2008 e
di 80 per il 2009 per coprire un congruo
numero di posti. Il provvedimento, però, è subordinato all'emanazione di un
regolamento, che tuttavia non ha visto ancora la luce, in quanto gli atti sinora
presentati nella scorsa legislatura hanno ricevuto il parere negativo della
Corte dei conti. Poiché i bandi debbono essere emanati entro il giugno 2008,
stiamo intervenendo urgentemente per scongiurare l'eventualità di bloccare
l'accesso alla carriera accademica di tanti giovani e di lasciare i fondi
congelati, così come intendiamo prolungare sino al 30 novembre i bandi per i
concorsi da professore ordinario e associato. Mi auguro che questo possa essere
un obiettivo condiviso, anche in questo campo, per dare in futuro certezze che
sono venute a mancare. Credo che si tratti di una priorità.
Poiché la retribuzione dei ricercatori è troppo bassa rispetto alla media
europea, ciò rende il ruolo meno appetibile da parte dei giovani di talento.
Occorre investire risorse perché i ricercatori universitari siano in numero
maggiore e meglio pagati. Da pochi giorni abbiamo reso operativo l'emendamento
presentato dal senatore Valditara che prevede l'aumento di 240 euro mensili per
le borse di dottorato. L'intervento di adeguamento si affiancherà ad una
riforma del dottorato stesso, che vogliamo improntata ad una drastica riduzione
del numero dei corsi, ad un carattere più intensivo della ricerca e ad una più
radicale internazionalizzazione. E proprio come fanno i grandi sistemi
internazionali, favoriremo in tutti i modi i passaggi dal mondo dell'impresa
all'università e viceversa, per evitare che ci siano ancora sacche di dottori
di ricerca anziani e ricercatori che il sistema non è in grado di assorbire.
Quanto alle nuove regole di reclutamento per professori e ricercatori, pensiamo
a procedure snelle e credibili, che assicurino meritocrazia e autonomia dei
singoli atenei. Ne discuterò a breve con il CUN e con gli organismi interessati
e mi limito, quindi, qui ad indicare alcune linee di indirizzo, che andranno poi
valutate e verificate. Occorre, innanzitutto, una verifica nazionale di idoneità,
riconosciuta da parte della comunità scientifica nel suo complesso. All'interno
di una lista di idonei, le università sceglieranno autonomamente colui che
ritengono lo studioso più capace nella produzione scientifica, più adatto a
richiamare finanziamenti dalle imprese e/o iscrizioni da parte degli studenti.
Nella lista degli idonei dovranno essere compresi, tramite regole di valutazione
e riconoscimento dei titoli internazionali, anche gli studenti che lavorano
all'estero, italiani o stranieri che siano. Ciò determinerà una crescente
internazionalizzazione dell'università italiana, che sarà più permeabile alle
energie di quanti, italiani e non, lavorano all'estero, anche sbarazzandosi di
tetti che in ragione della scelta decisa verso l'autonomia non hanno ragione
d'essere.
Il sistema meritocratico e di trasparenza con il quale saranno erogati i fondi
pubblici, basato sui risultati di ricerca e di didattica, indurrà
necessariamente i singoli atenei ad operare scelte responsabili e scoraggerà il
più possibile azioni clientelari. Questo sistema di reclutamento in due fasi
(attribuzione dell'idoneità su base nazionale e scelta del docente da parte del
singolo ateneo) si richiama all'impostazione della riforma Moratti, che non ha
purtroppo avuto attuazione nella precedente legislatura e che ritengo, invece,
opportuno applicare. Proprio in base al principio dell'autonomia responsabile,
è mia intenzione lasciare le università libere di chiamare, nei propri ranghi,
anche docenti che non provengano strettamente dal mondo accademico e le cui
caratteristiche rappresentino un valore aggiunto per gli atenei e per i corsi di
laurea. Si tratta di un tema delicato e mi rendo conto che è esposto a dei
rischi; per questo i meccanismi di selezione saranno comunque rigorosi e magari
verrà individuata una proporzione.
Il merito e la responsabilità non soltanto informeranno il meccanismo di
reclutamento, ma concorreranno anche a determinare almeno una parte della
retribuzione del professore e del ricercatore. Il contratto nazionale fisserà
solo la retribuzione di base, il resto sarà il frutto di una trattativa tra
atenei, docenti e ricercatori, fondata su criteri meritocratici.
Passando alla governance, la parola chiave per il riassetto del sistema
universitario italiano è proprio governance. Come tanti termini inglesi
di uso comune, anche questo ha un cuore antico, collocato nella civiltà
mediterranea. L'etimologia latina di governance, (guberno, o gubernatio)
richiama l'idea della guida, del governo della nave in mare, della responsabilità
di usare il timone secondo le aspettative di chi è a bordo. Il termine rimanda,
per certi versi, anche all'idea della capacità di rispondere delle proprie
scelte, della verifica e del controllo. Questo principio deve ispirare tutto il
mondo accademico, in tutti i suoi aspetti, da quelli scientifici a quelli
didattici, da quelli organizzativi a quelli finanziari. La sfida della governance
è la sfida dell'autonomia di governo responsabile degli istituti universitari.
So che i rettori delle università tengono particolarmente a questo tema. E
libere associazioni di università, quale ad esempio Aquis, hanno sviluppato
proposte e ragionamenti che mi paiono interessanti e che è mia intenzione
approfondire e sviluppare.
Una governance responsabile si basa su grande libertà di organizzazione;
sul passo indietro di una burocrazia statale che determini regole troppo rigide,
come spesso è avvenuto, anche recentemente; sull'accentuata individualizzazione
dei rapporti contrattuali che consente di valorizzare il merito di chi fa
ricerca e didattica e che rende gli atenei direttamente responsabili delle loro
scelte. Una governance moderna richiede l'introduzione di nuove figure,
in grado di garantire il successo organizzativo degli atenei e indirizzate a
reperire i finanziamenti esterni.
Ritengo che gli atenei debbano essere lasciati liberi di avvalersene, rimuovendo
ogni eventuale ostacolo legislativo alla loro libera auto-organizzazione e
limitando il ruolo dello Stato alla fissazione di alcuni paletti che rispettino
la natura di societas dell'università e garantiscano, però, a tutta la
collettività, un controllo rigoroso e trasparente.
E veniamo al welfare studentesco. Mi piacerebbe che le università
fossero sempre più comunità vive e stanziali di studio e ricerca, dove
studenti, docenti e ricercatori si arricchiscano reciprocamente. Occorre
incoraggiare la crescita di queste comunità con la creazione di nuovi alloggi
per studenti fuori sede, disincentivando lo scandaloso e crescente sfruttamento
degli studenti spesso costretti ad affitti elevatissimi e fuori mercato. Penso
ai campus, modellati sulla recente esperienza del collegio di Milano, di
Catania, di Torino, di Pavia, iniziative sorte grazie alla partnership
con le regioni in primis, ma anche con gli enti locali. Penso anche, più
modestamente, a delle residenze universitarie. In modo particolare su questa
materia desidero confrontarmi con il consiglio nazionale degli studenti
universitari, valutando le loro proposte e i loro suggerimenti.
La mia stella polare per la creazione di un nuovo welfare studentesco è
negli articoli 3 e 34 della Costituzione, laddove si fa riferimento al «compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana» e (con riferimento all'articolo 34) al
premio ai «più capaci e meritevoli». In cinquanta anni, questi obiettivi non
sono stati raggiunti, se non parzialmente. Alcune regioni italiane hanno saputo
compiere grandi sforzi e conseguire discreti risultati. Occorre fare tesoro
delle loro esperienze e continuare su questa strada. Anche in tal caso ritengo
urgente attivare un coordinamento con le regioni e gli enti locali che porti ad
una maggiore considerazione dello studente, che non è un problema ma una
risorsa, soprattutto per le città universitarie. Al fine di aiutare gli
studenti, dobbiamo incentivare la pratica dei prestiti d'onore, rendendo
l'erogazione più facile e di maggiore entità.
E veniamo all'eccellenza. In Italia vantiamo numerosi centri di eccellenza: la
Normale e la Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale, la SISA, l'Istituto di
scienze umane di Firenze, l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia,
la Scuola di alti studi, l'IMT di Lucca. Tali istituti stanno operando bene,
mostrando i risultati che possono essere raggiunti quando le parole autonomia e
responsabilità sono perfettamente coniugate. Lo strumento delle cosiddette «scuole
a statuto speciale» rappresenta una leva per l'eccellenza. L'Italia ha un
disperato bisogno di eccellenza e di ritornare ad essere capitale di cultura e
innovazione.
Queste realtà erano state «messe a sistema» da Letizia Moratti, chiamate
intorno a un tavolo che purtroppo, da due anni, non è stato più convocato.
Ritengo invece quel tavolo strategico per il Ministero e per tutto il mondo
universitario ed è mia intenzione riattivarlo immediatamente. Dobbiamo
proiettare, soprattutto, queste realtà ai vertici delle classifiche
internazionali, dobbiamo, sul loro modello, stimolare la nascita di altri poli
di eccellenza nelle varie parti del Paese e in modo particolare nel Mezzogiorno,
realtà che sappiano coinvolgere consorzi universitari, fondazioni, centri di
ricerca, nonché attrarre fondi privati.
Dobbiamo fare di queste realtà il vivaio da cui poter attingere la classe
dirigente del Paese. Le Grande école francesi, le università di Oxford
e Cambridge, gli atenei della Ivy League sono esempi cui guardare e a cui
trovare dei corrispettivi.
La pubblica amministrazione, innanzitutto, ha bisogno dei giovani formati in
queste scuole. Abbiamo avuto, nel recente passato, un esempio positivo che ha
saputo coniugare merito e impegno al servizio del Paese. Mi riferisco al famoso
primo corso-concorso per dirigenti pubblici, promosso da Sabino Cassese ormai più
di dieci anni fa, che attraverso una selezione durissima ha regalato alla
pubblica amministrazione alcuni dei suoi migliori dirigenti.
Passo ora al tema della ricerca. Sul capitolo dedicato alla ricerca intendo
proporre alla Commissione alcuni punti fondamentali: innanzitutto i compiti di
coordinamento del MIUR, il piano nazionale della ricerca, la rivisitazione degli
enti di ricerca, il ruolo di ricercatori e tecnologi e il trasferimento
tecnologico. Intendo innanzitutto rivendicare e attuare un forte ruolo di regìa
e di coordinamento del MIUR su tutte le attività di ricerca che si svolgono o
si progettano nel sistema Paese e sulle sue connessioni con la ricerca
internazionale, in primo luogo europea. Per rendere competitiva la ricerca
bisogna innanzitutto mapparla, razionalizzarla e darle coerenza. Servono quindi
una riorganizzazione della ricerca, una razionalizzazione delle sue risorse,
l'istituzione di nuovi criteri di valutazione, il coordinamento e la
finalizzazione verso obiettivi strategici.
Per fare questo, occorre rileggere coraggiosamente la frammentazione della
ricerca italiana, della sua gestione, del suo controllo e del suo finanziamento,
frammentazione che esiste sia in senso orizzontale, presso diversi dicasteri e
settori (università, enti di ricerca speciali pubblici e privati, dicasteri
come quelli della salute, dell'ambiente, dell'agricoltura, delle attività
produttive, dei beni culturali) e poi in senso verticale tra Europa, Stato,
regioni e altre istituzioni locali.
Mi limito ad un solo esempio, che riguarda le ricerche marine. Oggi presso il
MIUR oltre alla ricerca universitaria sono presenti a svolgere attività di
ricerca anche marina il CNR, l'INGV, l'OGS, la Stazione zoologica, e presso
altri ministeri l'ENEA, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare, l'APAT e una serie di consorzi di ricerca per la
pesca. Insomma, si tratta di una sfilza di istituzioni regionali per lo più
collegate alle ARPA, nonché, da ultimo, alcune società scientifiche che hanno
ottenuto finanziamenti per svolgere ricerca in prima persona, «appoggiandosi»
sulle università o sulle cooperative.
Tutti questi attori si muovono indipendentemente e senza alcun coordinamento sia
a livello nazionale che internazionale. Non si tratta certo di togliere o
avocare competenze di merito, di portafoglio e di settore, o legami col
territorio, o di interferire rispetto ad interventi speciali dettati da
particolari condizioni. Si tratta però di porre e di pretendere la fine di
duplicazioni, ridondanze, incoerenze di indirizzo e di obiettivo. Occorre
valutare realisticamente gli effetti negativi di queste dinamiche in termini di
pura e semplice competitività del sistema, in ultima analisi di sostenibilità
economica. Fino ad oggi è venuto a mancare, volutamente o meno, questo ruolo
trasversale di coordinamento attivo da parte del MIUR, che è, assieme alla
promozione della ricerca, la sostanza stessa della sua ragion d'essere. Lo
stesso lavoro di sistematizzazione va compiuto, innanzitutto, tra gli enti di
ricerca italiani. Per questo ho apprezzato l'idea di un'indagine conoscitiva
avanzata dall'onorevole Antonio Palmieri, che servirà a me, ma credo al
Parlamento tutto, a fare chiarezza e ad individuare i rami secchi.
È mia intenzione procedere, peraltro, alla completa spoliticizzazione degli
enti di ricerca. I loro futuri vertici saranno nominati in una rosa proposta da
appositi search committee di livello internazionale e rigidamente
vincolati, nel loro mandato, al raggiungimento degli obiettivi. Vorrei
richiamare la vostra attenzione sulla competenza e sull'autorevolezza che
dobbiamo chiedere, e dare, ai nostri ricercatori e ai nostri tecnologi. La
Commissione europea ha approvato nel marzo 2005 una raccomandazione riguardante
la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei
ricercatori, contenenti princìpi generali e prescrizioni in materia di
reclutamento, di progressione di carriera, di diritti e doveri, di mobilità,
che gli Stati membri sono invitati a recepire, al fine di «offrire ai
ricercatori dei sistemi di sviluppo di carriera sostenibili in tutte le fasi
della loro carriera» e perché «i ricercatori vengano trattati come
professionisti e considerati parte integrante delle istituzioni in cui lavorano».
In Italia - come sapete - siamo lontanissimi dal recepimento della
raccomandazione comunitaria. La situazione è disastrosa, tanto dal punto di
vista dello status giuridico, quanto da quello del reclutamento e della
retribuzione. Proseguirò il programma di rientro dall'estero dei «cervelli»,
ma soprattutto mi sembra essenziale impedire che fuggano e, anzi, strappare
possibilmente all'estero i «cervelli» migliori, offrendo loro prospettive. La
concorrenza tra sistemi Paese e l'internazionalizzazione diventano parole vuote,
se non si dà ai nostri ricercatori e tecnologi la dignità necessaria a sedersi
nei club internazionali. E non gliela possiamo dare, se il loro status
giuridico ed anche economico e i loro meccanismi di reclutamento e valutazione
non consentono di guardare loro negli occhi i colleghi. Uno dei miei obiettivi
è, pertanto, il recepimento della raccomandazione europea.
Ho già sviluppato, all'inizio del mio intervento, il tema delle risorse, che
entra a pieno titolo in una rigorosa riorganizzazione della macchina pubblica.
Vorrei toccare altri due punti, che riguardano il piano nazionale della ricerca
e il trasferimento tecnologico. Sul primo avremo tempo e modo di confrontarci in
maniera proficua e serrata. Da un primo giro di tavolo con gli stakeholder,
emerge chiara l'esigenza di puntare su alcuni settori di eccellenza e su alcune
specificità italiane. Soprattutto, è chiara la necessità di puntare a
progetti di ricerca di medio-lungo periodo, che possono essere affrontati solo
dal sistema pubblico, ma che nel loro percorso hanno ricadute immediate sulla
conoscenza.
Le risorse che i vincoli di bilancio concedono devono spingere alla loro
migliore allocazione possibile e certamente con attenzione prioritaria a quelle
tecnologie definite abilitanti: tra queste, ovviamente, le biotecnologie, le
nanotecnologie, gli ICT (Information comunication technology).
Due settori mi sono particolarmente cari e su questo vorrei chiedere poi il
contributo della Commissione perché credo che dobbiamo connotare politicamente
il tema della ricerca: penso all'agroalimentare, che rappresenta una delle punte
di lancia del made in Italy, sul quale, peraltro, è in atto anche un
progetto da parte di diverse fondazione bancarie, quindi con la possibilità di
recuperare anche qualche fondo, e sul quale poi si offre l'opportunità
dell'Expo 2015; penso infine che non si possa nemmeno trascurare la ricerca
sulle fonti energetiche rinnovabili.
Per quanto riguarda le linee di indirizzo, il Ministero intende promuovere un
ruolo attivo della ricerca italiana nell'ambito dell'European technology
platform, costituitasi su incoraggiamento della Commissione europea, al fine
di individuare gli obiettivi strategici di medio e lungo termine per la ricerca
europea e per attuare gli obiettivi della rinnovata strategia di sviluppo.
Le ETP sono guidate dai rappresentanti del mondo industriale e produttivo delle
filiere di interesse e coinvolgono tutti gli stakeholder di ciascuna
filiera, sia pubblici che privati. In alcuni settori e per alcune delle
piattaforme europee si è realizzato un corrispettivo italiano. L'obiettivo è
quello di identificare priorità di ricerca e di sviluppo tecnologico mirate
all'innovazione del settore a livello nazionale.
A partire dal 2006 sono stati costituiti, nel nostro Paese, piattaforme
tecnologiche italiane o gruppi di supporto a sostegno della Knowledge-based
bio-economy. In questa fase è molto importante promuovere le PTI,
illustrarne gli scopi e le finalità per creare coordinamento e sinergie anche a
livello sovraregionale.
Ho spesso citato nel mio intervento il rapporto tra pubblico e privato. La loro
alleanza è possibile ed auspicabile nonché l'unico modo - aggiungo - per avere
più risorse. Voglio però essere chiara. Non si tratta, come qualcuno può
pensare, di «piegare la ricerca al mercato». Si tratta di comprendere,
innanzitutto a livello filosofico e concettuale, che la ricerca, pubblica e
privata, ha un ruolo sociale, risolve i problemi del cittadino e ne migliora la
vita. Occorre, però, ricordare che tutti i processi di valorizzazione dei
risultati della ricerca, mediante meccanismi che definiamo di technology
transfer, possono generare valore aggiunto per chi li ha prodotti, creando
quindi un volano economico per finanziare la ricerca stessa,
come avviene nei migliori centri anglosassoni ed essere inoltre un motore di
innovazione per chi li sfrutta, che per essere competitivo necessita di poter
attingere ai risultati della ricerca no-profit.
Affinché il processo possa avvenire in modo efficace sono necessarie normative
chiare per la definizione dei diritti di proprietà industriale, con meccanismi
di incentivazione per i ricercatori che producano invenzioni, cultura e
formazione appropriata; se il ricercatore non ha questa cultura, non potrà
nemmeno valorizzare i risultati della sua ricerca. In questo senso è tipico il
frequente caso del ricercatore che pubblica prima di brevettare. Occorrono
allora strutture qualificate ed adeguate, i cosiddetti TTO (Technology
transfer office), presso i principali centri di ricerca, che possano gestire
in modo professionale tutte le fasi del technology transfer, dalla
brevettazione alla contrattualistica, dal marketing al business
development, alla definizione di un eventuale progetto industriale, e così
via; occorre, insomma, favorire la creazione dei cosidetti «incubatori», cioè
strutture fisicamente inserite all'interno di alcuni centri di ricerca, dove le
nuove iniziative possano nascere ed essere accompagnate in un processo di
sviluppo e consolidamento e dove realtà industriali già avviate e consolidate
possano trovare una sede adeguata che favorisca l'interazione con masse critiche
di ricerca in grado di dare maggiore competitività e favorire il technology
transfer.
In Italia si fa ricerca, ci sono risorse private, finanziarie e industriali che
potrebbero e vorrebbero investire nelle biotecnologie, nella biomedicina, nella
nanotecnologia. Tuttavia, non c'è una cultura e una struttura per il
trasferimento tecnologico, non c'è un'estesa capacità di dialogo tra i due
settori. Un ruolo importante nel dialogo tra ricerca, industria e mercato lo
possono giocare due elementi già presenti nello scenario: i progetti congiunti
tra enti di ricerca e industrie, i parchi e i distretti tecnologici.
I distretti e i parchi tecnologici costituiscono in teoria luoghi privilegiati
per alimentare la filiera dell'economia della conoscenza, perché mettono a
contatto tutti gli attori e i momenti del meccanismo di generazione di valore
economico a partire dalla ricerca, sia di base che applicata, fino all'industria
e al territorio; tutti questi fattori vengono fatti sedere attorno ad un
medesimo tavolo. Prevedono in genere infrastrutture tecnologiche centralizzate e
disponibili e servizi per assistere le varie fasi: servizi per fund rising,
competenze per il business planning, marketing, consulenza legale,
brevettuale, aziendale. Sono quindi il laboratorio ideale per coltivare e
realizzare l'applicazione della ricerca e la sua valorizzazione economica. Nella
formazione post laurea, di terzo e quarto livello, si dovrebbero individuare con
chiarezza percorsi per creare manager specializzati in questa direzione.
E mi avvio a concludere. Signor presidente, onorevoli deputati, so di non essere
stata breve e, nonostante ciò, di non aver toccato tutti gli argomenti che mi
premevano. Mi importa, al di là di un carniere di argomenti, aver fornito un
metodo di lavoro, alcuni princìpi e alcune priorità di azione del Governo. Il
filo rosso che ho cercato di utilizzare per tenere insieme i miei ragionamenti,
oltre ai concetti chiave di autonomia, valutazione, merito, semplificazione
legislativa e centralità dei giovani, si chiama futuro del Paese. Ciascuno di
noi è chiamato, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, quale che sia
l'orientamento politico di riferimento, a scrivere la propria parte e
possibilmente a scriverla insieme. Sono certa
che questa Commissione contribuirà autorevolmente alla realizzazione di questo
fine comune attraverso un confronto continuo e costruttivo.
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200806/0617/html/07/
Indice Scuola Elettrica - generico

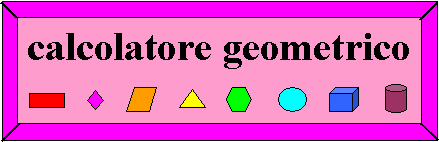

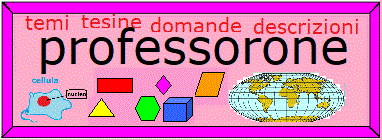
Scuola
Elettrica
Altre applicazioni
Mappa per tipo di scuola
Indice di tutte le pagine del
sito
Guida per navigare
Richiesta informazioni
Scuola
Elettrica
 al
presidente Aprea e al presidente Possa di separare in due distinti momenti la
mia audizione. Istruzione, università e ricerca scientifica costituiscono un tutt'uno,
hanno per protagonista lo stesso soggetto, la persona nel suo cammino di
crescita e di conoscenza, e sono parte dell'unica infrastruttura dell'educazione
e del sapere. Tuttavia, la loro complessità, la diversità di linguaggi e in
parte di problemi, la necessità di focalizzare sia pure a grandi linee il
dibattito e di dare alla Commissione la più ampia possibilità di esprimersi
meritano da parte di tutti noi l'esercizio di un duplice sforzo.
al
presidente Aprea e al presidente Possa di separare in due distinti momenti la
mia audizione. Istruzione, università e ricerca scientifica costituiscono un tutt'uno,
hanno per protagonista lo stesso soggetto, la persona nel suo cammino di
crescita e di conoscenza, e sono parte dell'unica infrastruttura dell'educazione
e del sapere. Tuttavia, la loro complessità, la diversità di linguaggi e in
parte di problemi, la necessità di focalizzare sia pure a grandi linee il
dibattito e di dare alla Commissione la più ampia possibilità di esprimersi
meritano da parte di tutti noi l'esercizio di un duplice sforzo.